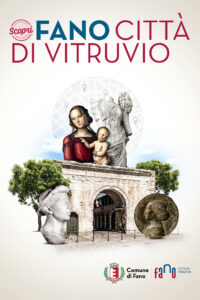La Fano barocca
LA MAGNIFICENZA DEL BAROCCO

A Fano anche l’arte barocca ha lasciato la sua splendida impronta: magnifici esempi di questa epoca fastosa sono senz’altro la Cappella Nolfi, situata presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta, che conserva al suo interno un patrimonio unico di dipinti, affreschi, decori e preziosi marmi e la Chiesa di San Pietro in Valle, vera e propria galleria di ori, stucchi e pitture e uno degli esempi più eclatanti dell’arte barocca in terra marchigiana.
Vuoi visitare la Fano barocca?
Scopri tutte le possibilità e scegli la soluzione più adatta a te!
Scopri tutti i musei e le collezioni presenti in città,
gli orari di apertura e le modalità di visita.

La Fano Visit Card è la chiave di accesso alla città.
Scopri tutte le possibilità e le agevolazioni che ti offre!
Scarica la App VisitFano e visita la città in modo inedito e immersivo.
Cappella Nolfi
Fastosa e riccamente decorata con 16 episodi della Vita della Vergine dal Domenichino, la seicentesca Cappella Nolfi, situata presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta, è uno degli esempi più significativi del Barocco fanese e conserva al suo interno un patrimonio unico di dipinti, affreschi, decori e preziosi marmi.
Nell’attuale cattedrale di Santa Maria Assunta, principale luogo di culto della città, spicca per magnificenza la seicentesca cappella Nolfi, terza a destra della navata laterale. Ceduta dal Vescovo Tommaso Lapi a Guido e Cesare Nolfi. I due patrizi fanesi nel 1604 attuarono la completa trasformazione della cappella, arricchendola di dipinti, affreschi e preziosi marmi e rendendola così un prezioso esempio di arte barocca.
Nel 1606, la famiglia Nolfi decise di commissionare al pittore anconetano Andrea Lilli la realizzazione della pala d’altare rappresentante il Paradiso e l’Assunta. Nello stesso anno, fu stipulato il contratto per la creazione dell’altare stesso, basato sul disegno di Matteo Castelli di Como. Le due virtù teologali, la Fede e la Speranza, poste sopra il timpano, furono scolpite dallo scultore fiorentino Francesco Sonzino.
I monumenti funebri dei due fratelli Cesare e Guido Nolfi, posti ai lati della cappella, furono abbelliti con busti dello scultore Francesco Caporale. Dopo la morte di Cesare nel 1612, il fratello Guido assunse l’incarico di portare a termine i lavori della cappella. La decorazione in stucco fu successivamente completata tra il 1616 e il 1617 da Pietro Solaro, stuccatore, su disegno dell’architetto Girolamo Rainaldi.
Ma l’intervento di maggior pregio, quello che ha reso celebre la cappella, è sicuramente lo splendido ciclo affrescato, Vita della Vergine, opera di Domenico Zampieri detto il Domenichino.
Fu Guido Nolfi stesso a coinvolgere il famoso pittore bolognese avendolo conosciuto a Roma dove il giurista fanese ricopriva prestigiosi incarichi presso la curia papale. L’artista accettò l’offerta del Nolfi di decorare la cappella di famiglia stipulando nel 1617 un contratto per la realizzazione di sedici affreschi rappresentanti le Storie della Vergine di stile vagamente rinascimentale. Realizzati in seguito fra il 1618 e il 1619, i lavori di decorazione della cappella proseguirono in realtà anche dopo la morte di Guido Nolfi avvenuta nel 1627 con la realizzazione di altre figure allegoriche e angioletti.
Il complesso decorativo fu notevolmente danneggiato nel 1749 a seguito di un incendio divampato nel coro e a causa dell’umidità. Nel 1762 i dipinti furono restaurati ma successivamente quasi abbandonati. Il restauro definitivo, avvenuto in tempi recenti, ha permesso di restituire questo splendido esempio del barocco alla sua città.

Chiesa di San Pietro in Valle
Magnifico esempio di integrazione fra architettura, decorazione plastica e pittura, la Chiesa di San Pietro in Valle è un connubio ottimamente riuscito tra i numerosi linguaggi della provincia pittorica marchigiana e le grandi tradizioni culturali romana e bolognese, e uno degli esempi più eclatanti della fastosa arte barocca in terra marchigiana.
Così denominata perché sorta presso l’antico dislivello (ad vallum) fra la città romana e il litorale adriatico, la Chiesa di San Pietro in Valle, situata nel pieno centro storico della città, rappresenta uno dei migliori esempi del barocco marchigiano.
Costruita sulle rovine di un’antica chiesa fondata dalla Congregazione dei Padri Oratoriani nell’VIII secolo, la nuova struttura di maggiori dimensioni fu terminata nel 1610 grazie al contributo delle famiglie nobili di Fano, in particolare quella di Girolamo Gabrielli. La chiesa, edificio con pianta a croce latina, con sei cappelle laterali, coronato da un alto tamburo con cupola, fu consacrata nel 1617 senza che fossero ancora terminate le ornamentazioni. Con la nuda facciata rimasta priva del previsto rivestimento e i suoi mattoni a vista a cui fa da contrasto l’interno ricchissimo di ori, stucchi, marmi e pitture, la Chiesa di San Pietro in Valle è certamente uno degli esempi più eclatanti della fastosa arte barocca in terra marchigiana.
L’ornamentazione della chiesa fu realizzata tra il 1618 e il 1620 dall’artista romano Pietro Solari, impegnato a Fano anche presso la Cappella Nolfi in Cattedrale, e quello urbinate Antonio Viviani detto il Sordo. Di quest’ultimo sono i grandi affreschi che ornano le volte della navata e del presbiterio come pure quelli ai lati del finestrone di facciata. Sue anche l’Annunciazione che sovrasta la parete dell’altare maggiore e le due tele laterali della cappella dedicata a S. Paolo.
La sfarzosa decorazione barocca della cupola, fu eseguita invece dal bolognese Lauro Buonaguardia nel biennio 1699-1700.Volgendo lo sguardo in alto, all’incrocio dei bracci della pianta a croce latina, spicca il contrasto tra il bianco e l’oro in un tripudio di angeli, beati e, all’interno dei tondi, i quattro evangelisti.
Di eccezionale valore e bellezza, la “galleria di rare pitture” che decorava l’altare maggiore e le sei cappelle laterali. Nella prima cappella a sinistra spicca, per grazia stilistica, l’Annunciazione di Guido Reni , mentre in quella a destra, la luminosa Vergine che appare a S. Filippo Neri di Luigi Garzi.
Tra gli altri nomi eccellenti che lavorarono al cantiere della chiesa, lasciando opere di straordinaria qualità stilistica, il Guercino, il pesarese Simone Cantarini e G. F. Guerrieri di Fossombrone.
Diverse opere furono trafugate in Francia durante l’età napoleonica, tra cui lo splendido dipinto di Guido Reni del 1626 Cristo consegna le chiavi a San Pietro, attualmente esposto al museo del Louvre, mentre a San Pietro in Valle rimane la copia ottocentesca di Carlo Magini; le altre, preziosissime opere, sono oggi conservate presso la Pinacoteca del Palazzo Malatestiano.

Piazza XX Settembre e la Fontana della Fortuna
Se c’è un luogo che più di altri sa esprimere l’identità eclettica di Fano e la sua capacità di fondere armoniosamente le tante testimonianze del suo passato, questo è Piazza XX Settembre. Cuore pulsante della città, fulcro della vita cittadina oggi come nell’antichità, in questa piazza convivono, dialogando tra loro, epoche e architetture talmente lontane e diverse, da farne il simbolo della Storia stessa della città.
Una storia che da 2000 anni ha sempre al centro la Fortuna!
Piazza XX Settembre a Fano è un crocevia unico di testimonianze delle tante epoche che hanno segnato la storia di questa città. Ubicata al centro di Fano, vitale fulcro della vita sociale e culturale della città, la piazza è la summa perfetta della storia di Fano, quella visibile e quella invisibile.
Chiamata Piazza Maggiore agli inizi del Novecento, Piazza XX Settembre si apre ai piedi del trecentesco Palazzo del Podestà o della Ragione, ora sede del Teatro della Fortuna. A fianco del teatro domina la Torre Civica ricostruita in sostituzione del campanile settecentesco abbattuto dalle truppe tedesche in ritirata nel 1944, e Palazzo Bambini, Sulla facciata del Palazzo Bambini, una meridiana, oggi scomparsa, svolgeva la funzione di calendario solare e mostrava il Mezzogiorno Medio dell’Europa Centrale e il Mezzogiorno Vero di Fano. Attraverso il monumentale Arco Borgia-Cybo della fine del ‘400, dal Palazzo del Podestà, si accede alla Corte Malatestiana. Unico edificio religioso nella piazza e uno dei più antichi di tutto il centro storico, la chiesa di San Silvestro, conosciuta anche come Madonna di Piazza per via del seicentesco dipinto della Madonna di Piazza attribuito a Giovanni Baglioni. Sotto il selciato, caratterizzato da una grande stella centrale del XVIII secolo, si apre la piazza invisibile: cospicui resti archeologici di età romana, custoditi nei sotterranei dell’Ufficio Informazioni del Comune e del Palazzo Malatestiano, nelle cantine di Palazzo Bambini, sotto la platea del Teatro della Fortuna, nelle fondamenta della Torre Civica, ci ricordano le origini e le fondamenta della città.
Ma è sul lato occidentale, quello che affaccia su Corso Matteotti, che si erge il simbolo di Piazza XX Settembre e dell’intera città: la Fontana della Fortuna dove campeggia, fiera e indomita, la statua bronzea della Dea della Fortuna.
La fontana, all’ampio bacino a marmi policromi, fu interamente rinnovata nel 1697-99 dal veneziano Ludovico Torresini. L’originaria struttura era costituita da un bacino ottagonale in marmo, privo di decorazioni scultoree. La fontana era alimentata dall’acquedotto romano tramite condotte in terracotta fino alla Fontana dello spiazzo del Molino, presso l’Arco d’Augusto, e successivamente tramite tubi di piombo e cotto fino alla piazza. La statua bronzea della Dea Fortuna venne realizzata nel 1593 ad opera dell’artista urbinate Donnino Ambrosi, ma a causa delle sue nudità eccessive, fu collocata in una nicchia del palazzo dei Priori e sostituita da un grande vaso in bronzo. La controversia su dove posizionare la statua durò più di un secolo, finché venne finalmente sistemata sulla fontana nel 1611. Attualmente, la statua bronzea è conservata presso il Museo Civico, mentre sulla fontana è stata collocata una copia.
La statua della Dea Fortuna ha una particolarità: se si osserva attentamente la figura, emerge una discrepanza tra il velo e i capelli della dea Fortuna: il velo fluttua in una direzione, mentre i capelli si muovono in quella opposta.

Palazzo Montevecchio
Nel cuore storico di Fano sorge una dimora patrizia tra le più grandi ed eleganti della città, un palazzo del ‘700 appartenente all’importante famiglia nobile dei Montevecchio ed emblema della rinascita culturale ed architettonica della città.
Palazzo Montevecchio fu costruito a partire dalla metà del 1700, la progettazione e realizzazione furono opera di Alfonso Torreggiani e Arcangelo Vici e, infine, Biagio Biaschelli al quale si deve la parte centrale della facciata. Il palazzo è appartenuto all’antica famiglia dei conti di Montevecchio fino alla prima metà del XX secolo, casato che annovera importanti protagonisti della storia cittadina e valorosi condottieri, tra cui Giulio di Montevecchio che si occupò personalmente dell’edificazione dell’attuale dimora.
La parte centrale della facciata è caratterizzata da un imponente portale barocco di pietra fiancheggiato da colonne tuscaniche che sorreggono la balaustra del balcone. Una volta entrati nel palazzo non si può non rimanere affascinati dal grande atrio a colonne, nel cui cortile interno svetta la splendida fontana con la statua del dio Nettuno e un elegante ninfeo ellittico. Di grande impatto visivo è sicuramente il grande scalone d’onore, l’elemento architettonico tipico delle dimore patrizie settecentesche. Struttura molto scenografica che parte dal pozzo centrale e sale fino all’ultimo piano in un tripudio di nicchie, colonne e statue di marmo, il palazzo oggi è internamente suddiviso in diversiappartamenti, così come il maestoso salone di rappresentanza che in passato aveva le volte dipinte, purtroppo oggi non più visibili; rimangono solo poche decorazioni ben conservate nelle stanze del secondo piano.

Pinacoteca del Museo del Palazzo Malatestiano
Istituita nel 1898, la Pinacoteca ospita una delle più pregevoli raccolte di dipinti delle Marche e testimonia l’excursus della pittura a Fano e nel territorio marchigiano dal XIV secolo ai giorni nostri, evidenziando i contatti e le influenze con differenti correnti artistiche e scuole pittoriche come quella veneta, bolognese e romana.

La raccolta originaria della Pinacoteca è composta da dipinti provenienti da edifici religiosi dismessi, a cui nel corso del tempo si sono aggiunti donazioni e lasciti come la collezione del collezionista Antonelli e il lascito Vici Martelli. Le opere sono esposte seguendo principalmente un criterio cronologico: al primo piano si trovano la Sala del Caminetto con opere del XIV e XV secolo tra cui le pale d’altare come il Polittico di Michele Giambono e del Maestro di Roncaiette, la Madonna col Bambino in trono fra i santi Elena, Zaccaria, Sebastiano e Rocco di Giovanni Santi, padre di Raffaello. In questa sale è possibile anche ammirare il farsetto di Pandolfo III Malatesti, indumento che solitamente veniva indossato sotto l’armatura, rinvenuto durante la riesumazione della mummia del condottiero nella tomba presso l’ex Chiesa di San Francesco.
Accanto alla sala del Caminetto si apre la Sala Grande, luogo di rappresentanza già all’epoca del signore Pandolfo III Malatesti, con copertura a capriate e portale di accesso in pietra che ospita dipinti del XVI e XVII secolo. Tra le opere più interessanti la pala dipinta dai pittori fanesi Bartolomeo e Pompeo Morganti con la Resurrezione di Lazzaro e San Michele Arcangelo. Notevole è anche la collezione di opere di scuola bolognese provenienti dalle chiese cittadine: l’Annunciazione di Guido Reni, il Davide con la testa di Golia attribuita tradizionalmente al Domenichino, l’Angelo Custode del Guercino, le opere del forsempronese Giovanni Francesco Guerrieri e quelle del pesarese Simone Cantarini. Al piano terra attraverso un portale ad arco acuto originario del periodo malatestiano si accede alla Sala Morganti, caratterizzata da un soffitto a travi a vista con mensole intagliate, forse destinata ad armeria in epoca malatestiana e poi ad archivio comunale ed ora destinata ad esposizioni temporanee.
CERAMICHE E NUMISMATICA
Al piano mezzanino, a pochi passi dalla biglietteria, è possibile accedere alla Sala delle Ceramiche e all’attigua Sezione della Numismatica. All’interno della prima sala, nella vetrina al centro, è possibile osservare manufatti e frammenti, parte dei quali restaurati, databili tra il XIV e il XVIII secolo. La provenienza dei lavori è in parte locale, ma sono presenti anche manufatti provenienti da Urbania, l’antica Casteldurante. Si possono ammirare albarelli e pillolieri facenti parte della serie di vasi da farmacia provenienti da diverse farmacie e dall’antico ospedale, decorati con la caratteristica “rosa pesarese”, realizzati nel 1803 dalla manifattura Casari e Callegari di Pesaro e alcuni pezzi del servizio da tavola in porcellana del 1782 eseguito per il Comune di Fano dalla manifattura Veneziana di Geminiano Cozzi.
A fianco della sala delle ceramiche è esposta una campionatura della collezione numismatica costituita da monete romane repubblicane e imperiali, medievali e moderne di varie zecche italiane, comprese quelle battute dalla zecca operante a Fano dal 1414 al 1796, oltre che da alcune medaglie tra le quali è da ricordare la bellissima serie di “Medaglie Malatestiane” realizzate da Matteo de’ Pasti per Sigismondo Malatesti nel 1446.
Pinacoteca San Domenico
Monumentale tesoro architettonico custodito tra le mura della città, la Ex chiesa di San Domenico, è oggi una sede della pinacoteca d’arte sacra della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e ospita opere su tela, legno e affreschi dal XIV al XVIII secolo.

Monumentale chiesa sconsacrata le cui fondamenta furono fatte probabilmente costruire nel 1216 per ordine di un sacerdote dell’ordine domenicano, a seguito di importanti lavori di restauro, la ex Chiesa di San Domenico è oggi una interessante pinacoteca di arte sacra
L’ampliamento della chiesa avvenne verso la fine del XIV secolo secondo lo stile gotico, mentre all’inizio del ‘700 l’architetto Francesco Gasparoli modificò gli interni con altari tardo-barocchi. In seguito ai danni strutturali subiti durante la seconda guerra mondiale è stata necessaria una lunga serie di restauri conclusasi nel 2006 che portò alla luce magnifici affreschi medievali tra cui spiccano quelli della Vita di San Giovanni Battista attribuiti ad Ottaviano Nelli.
La chiesa racchiude anche le spoglie della nobile famiglia di Ugolino e Pietro De Pili, e la tomba di Jacopo Del Cassero di dantesca memoria.
La pinacoteca accoglie dipinti che vanno dal XIV al XVIII secolo, tra cui la celebre pala d’altare del Guercino raffigurante lo Sposalizio della Vergine, commissionata dalla famiglia Mariotti di Fano nel 1649; tele di Simone Cantarini, tra cui la Madonna della Rosa e Agar e Ismaele; inoltre opere di Sebastiano Ceccarini e Simone De Magistris, di Giovan Francesco Guerrieri (autore della bella Maddalena penitente, firmata e datata 1611, e del Miracolo dei pani e dei pesci, già nella chiesa fanese dei Santi Filippo e Giacomo), di Federico Barocci, Palma il Giovane, Federico Zuccari e altri importanti pittori del XVII secolo.
La Pinacoteca di arte sacra contiene dipinti che vanno dal XIV al XVIII secolo, le opere d’arte originarie della chiesa ricollocate al loro posto, dopo alcuni necessari restauri.
Così anche gli affreschi e i dipinti murali hanno restituito le loro cromie originali grazie ad interventi di consolidamento e recupero. Il tutto è stato poi corposamente integrato dalla collezione d’arte già di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, vale a dire ventisette tra tele e tavole, precedentemente ospitate all’interno del Palazzo Malatestiano. A completare l’importante collezione si trovano alcuni elementi lapidei e lignei che già facevano parte del tempio e che sono stati, del pari, trattati e/o ricollocati nelle sedi originarie. Tra le opere più prestigiose ricordiamo la celebre pala d’altare del Guercino che ritrae lo Sposalizio della Vergine e che fu commissionata dalla famiglia Mariotti di Fano nel 1649. Altre opere di rilievo sono quelle di Simone Cantarini, tra cui la Madonna della Rosa e Agar e Ismaele, e le tele di Sebastiano Ceccarini, Simone De Magistris, Giovan Francesco Guerrieri con la sua Maddalena penitente, e il Miracolo dei pani e dei pesci.